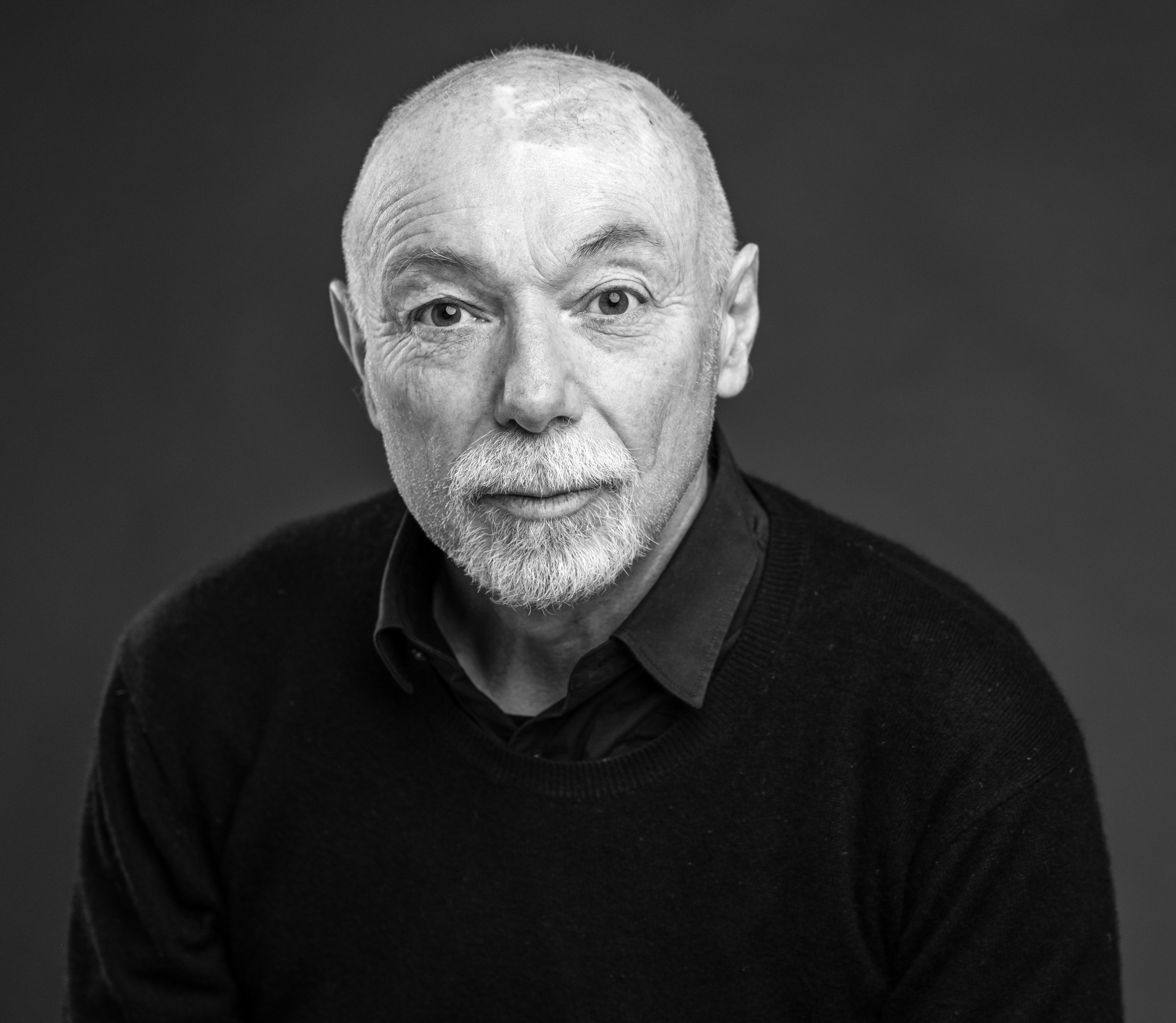«Sono stanco». Intervista a Paolo Nori
Foto di Claudio Sforza (cortesia dell’autore, tutti i diritti sono riservati).
Da più di vent’anni, molti dei grandi scrittori russi andrebbero letti in italiano con inflessione parmigiana. Non “parmense”, perché «parmensi son quelli della provincia», mentre Paolo Nori, che li ha tradotti, è “parmigiano”, nato a Parma e cresciuto a Parma. Altrove ci ha vissuto ed è (quasi) morto due volte, ma oggi è ancora lì, nella città dove ha studiato e si è laureato in lingua e letteratura russa.
Il suo percorso da autore inizia nel 1996, come raccontato nell’ultimo libro: «Ma cosa vuoi scrivere? Un romanzo?» si ripeteva. «Ma non ti rendi conto che sei solo una merda e che non hai nessuna speranza di essere altro?». Eppure Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij (2021) si classifica terzo al Campiello 2021, Chiudo la porta e urlo (2024) quarto allo Strega 2025. Attualmente Nori è docente di scrittura alla Scuola Karenin (da lui fondata) e di traduzione editoriale all’Università IULM. Scrive, legge e parla di continuo, sul web e in giro per l’Italia.
Niccolò Vittorio Pasetti
Niccolò Vittorio Pasetti: Rapone apre ogni puntata di Tintoria con «Come stai?», e tutti ridono. Deve essere un ragazzo intelligente, oltre che simpatico. Non c’è in effetti miglior modo di rompere il ghiaccio che farlo rompere a qualcun altro: si veste una battuta da domanda e, in un attimo, l’intervistato si trova a condurre la conversazione.
In faciem Raponis, cosa vorrebbe le fosse chiesto per iniziare un’intervista, che non le hanno mai chiesto?
Paolo Nori: Sono stato a Tintoria e quando Rapone mi ha chiesto «Come stai?» gli ho risposto «Sono stanco», che era vero, e, in generale, per me, è vero quasi sempre.
Non c’è una cosa che vorrei mi chiedessero.
Io, a dire la verità, se mi fanno delle interviste sono contento, se non me le fanno sono contento lo stesso (senza offesa).
NVP: Nel decimo capitolo di Chiudo la porta e urlo, il 10.9 § si intitola «Un senso». Se si pensa a A cosa servono i gatti, A cosa servono i russi?, o all’inizio di Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij («Che senso ha, oggi, […] leggere Dostoevskij?») sembra di vederla alla costante ricerca di quel «senso dell’universo» di cui parla in relazione alla Fondazione di Baldini. È così? Anche lei ha quell’«affetto per le cose» che aveva lui?
PN: Io, tutte le persone che conosco, si interrogano più o meno tutti, sul senso dell’universo. Forse conosco delle persone strane; per i miei conoscenti, ma credo un po’ per tutti, forse vale quel che dice l’opera numero 13 delle Opere complete di Learco Pignagnoli, che copio qua sotto:
Opera n. 13
“Tranne me e te, tutto il mondo è pieno di gente strana. E poi anche te sei un po’ strano”.
NVP: Da Due volte che sono morto, la morte è un tema che tocca spesso. Anche Chiudo la porta e urlo ne è intriso. Che rapporto ha con la morte?
PN: Un buon rapporto, mi sembra. Credo sia un tema che ha a che vedere anche con libri precedenti, Bassotuba non c’è e Grandi ustionati, per esempio; credo sia difficile scrivere un romanzo senza che la morte sia, in qualche modo, implicata. Io credo di essere, comunque, il contrario di un ipocondriaco, non so se la parola esiste, ma la uso; credo di essere un ipercondriaco, non ho paura, oggi, di morire.
So che devo morire e, fin da ragazzo, facevo l’università, ricordo con piacere la quartina di Metastasio «Non è ver che sia la morte Il peggior di tutti i mali; È un sollievo de’ mortali Che son stanchi di soffrir».
NVP: Una domanda sulla traduzione. Quando non le viene commissionato un lavoro, come sceglie cosa tradurre?
PN: Nessuna traduzione mi è stata commissionata, le ho sempre proposte io o, in casi rarissimi (mi ricordo per esempio Un miliardo di anni prima delle fine del mondo, dei fratelli Strugackij) me l’hanno chiesto e io, letto il libro, ho accettato con piacere, ma non era una commissione, era una gentile proposta. Io scelgo di tradurre le cose che mi piacciono.
NVP: Tradurre per lei è più come dipingere o come scolpire? Mi spiego. Si parte dal senso dell’originale e si soppesano le parole, le si aggiunge, per riuscire a darne una rappresentazione; oppure si lavora per sottrazione, dal pieno, per far emergere da ciò che già c’è il senso dell’originale?
PN: Tradurre, per me, è come eseguire un pezzo musicale, al pianoforte, o alla tromba; ha molto a che fare con la musica, col suono, col significante. È trovare un altro significante, un altro suono, a una cosa che ne ha uno che, per chi non parla russo, è incomprensibile.
NVP: Rimanendo nell’orbita dell’arte: qual è il primo artista o il primo quadro che le viene in mente pensando a Mosca-Petuškì di Venedikt Erofeev? Perché?
PN: Vladimir Škinkarev e il suo monumento a Lenin visto da dietro, che è un quadro che conoscono in pochi così come in pochi, in Italia, conoscono Mosca-Petuški. Tutti e due, mi sembra, sperimentano, nell’universo sovietico, una infinita libertà individuale, che è una cosa che merita tutta la mia ammirazione.
NVP: Che scriva del Parma o di Anna Achmatova, non viene mai meno la sua identità linguistica. Crede che il processo di cristallizzazione del suo stile sia giunto a piena maturità?
PN: Grazie per la sua considerazione sulla mia identità linguistica. Io sono la persona meno indicata, a parlare del modo in cui scrivo, non me ne rendo tanto conto e non voglio rendermene tanto conto per non imitarla. Quella pratica lì io vorrei che restasse una pratica un po’ misteriosa, per me. Detto questo, da uno sguardo distratto, lontano, ho come l’impressione che la mia scrittura non sia cristallizzata e credo proprio che non succederà mai, morirò prima (per tornare a una sua domanda precedente, mi piacerebbe, morire prima).
NVP: Ultima domanda, forse. Quanto c’è di inesplorato nel panorama letterario della Russia contemporanea? Come valuta la produzione attuale?
PN: Ho pubblicato un Corso sintetico di letteratura russa (si intitola I russi sono matti) dove dico che, secondo me, la letteratura russa è finita nel 1991, con la pubblicazione di Mosca–Petuški. Dopo la fine dell’Unione Sovietica, gli scrittori russi hanno, come noi occidentali, il problema di vendere e uno degli scrittori russi più venduti, Boris Akunin, ha pubblicato dei gialli storici che, quando ho letto il primo, mi sembrava di leggere Carlo Lucarelli tradotto in russo.
NVP: Dopo diversi anni, Gogol' Maps (il viaggio che Nori organizza in Russia nei luoghi della letteratura, NdR) ha rivisto finalmente la luce. Ci saranno differenze rispetto alle edizioni passate?
PN: No. Il programma è praticamente lo stesso dell’edizione del 2020 che è saltata per la pandemia.